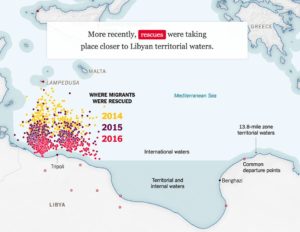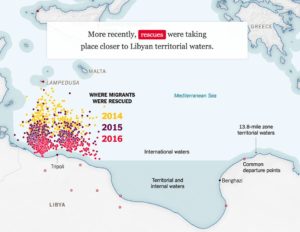
Il Mar Mediterraneo: una delle più congestionate rotte migratorie e di traffico di esseri umani al mondo. Il problema più grande per l’Europa, ma soprattutto per l’Italia, è l’oltraggiosa e confusionaria speculazione propria di diverse realtà nascoste dalla parola “ONG”. Come reagire? Il primo passo è rendere più difficile l’attracco nei porti Italiani alle navi degli atri Paesi, anche attraverso la minaccia o l’effettivo abbandono della Missione Triton. Il secondo passo è il sequestro e potenzialmente la confisca dei vascelli, l’arresto degli equipaggi e la loro denuncia, unitamente a quella degli armatori, per il reato di “associazione per delinquere finalizzata all’immigrazione clandestina”. Il terzo passo, infine, è l’interruzione dell’invasione in atto, attraverso la soluzione di un “problema” chiamato Libia, mediante l’impiego della Forza di Reazione Rapida della NATO, preferibilmente, ma non obbligatoriamente, con l’approvazione delle due entità governative che reggono le sorti del Paese Nord-Africano.
“Oh, miei fratelli! amate la Patria. La Patria è la nostra casa: la casa che Dio ci ha data, ponendovi dentro una numerosa famiglia che ci ama e che noi amiamo, con la quale possiamo intenderci meglio e più rapidamente che con altri, e che per la concentrazione sopra un dato terreno e per la natura omogenea degli elementi ch’essa possiede, è chiamata a un genere speciale d’azione. La Patria è la nostra lavoreria: i prodotti della nostra attività devono stendersi da quella a beneficio di tutta la terra; ma gli strumenti del lavoro che noi possiamo meglio e più efficacemente trattare, stanno in quella, e noi non possiamo rinunziarvi senza tradire l’intenzione di Dio e senza diminuire le nostre forze. Lavorando, secondo i veri principi, per la Patria, noi lavoriamo per l’Umanità: la Patria è il punto d’appoggio della leva che noi dobbiamo dirigere a vantaggio comune”. (Giuseppe Mazzini)
Incipit. La Costituzione che lo scorso anno ho difeso dal tentativo di stupro perorato da Matteo Renzi & Co. dovrebbe essere interpretata per quel che è: un coacervo di diritti, doveri e prescrizioni destinate a uno Stato libero e indipendente e ai suoi cittadini. Già, i cittadini; gli Italiani prima di tutto e con essi, tuttalpiù, gli stranieri legalmente autorizzati a risiedere o a soggiornare sul territorio della Repubblica. Estendere il valore della Sacra Carta a soggetti indesiderati o indesiderabili, clandestinamente ed illecitamente giunti all’arrembaggio delle Italiche sponde non può e non deve essere. Per loro, soltanto il diritto di essere nutriti e curati il tempo necessario per poi essere aviotrasportati, in tutta sicurezza, a casa loro.
In principio fu la (scusa della) Democrazia. Guardiamoci attorno. Non v’è giorno in cui, girando per le nostre città, non ci si trovi a riflettere e ad imprecare circa le ragioni che abbiano portato l’Italia a diventare un grande campo di raccolta di masse difficilmente e, a ragione, etichettabili come “profughi”, migranti o richiedenti asilo. E non v’è giorno che non si finisca per prendere atto che il nostro Paese non sia più il confine meridionale dell’Europa, bensì quello nord dell’Africa…
La responsabilità di ciò è ascrivibile a due fattori preponderanti: l’impreparazione, o meglio, la stupidità della Politica di Governo che dal 1991 in poi ha retto le sorti di Roma e soprattutto, l’improvvida decisione di agevolare il tracollo della Libia, bombardandola qua e là, presa da David Cameron, Nicolas Sarkozy e dal “Premio Nobel per la Pace” Barack Obama. Certo, non che vedessi con favore il perdurante ricatto del dittatore Muammar Gheddafi (cui un certo Silvio Berlusconi pareva invece essere ben disposto, ndr). E’ indubbia, tuttavia, l’efficacia del suo Regime come “freno” alle partenze verso i porti Italiani (fatto comprovato dai dati dallo UNHCR, Alto Commissariato per i rifugiati, delle Nazioni Unite). La Storia racconterà sempre le responsabilità di quei tre politicanti, “portatori di Democrazia a comando”, accecati dalle proprie brame di gloria e potere, nate e cresciute sull’onda lunga delle cosiddette “Primavere Arabe”. Parimenti, la Storia racconterà il loro mancato giudizio al cospetto del TPI, come Criminali di Guerra, non tanto e non solo per aver attaccato uno Stato Sovrano con la scusa di rendere libero il popolo, mascherando, in realtà, interessi legati ai Petrodollari (come già avvenne l’Iraq di Saddam Hussein, con Bush Jr. e Blair, ndr), quanto e soprattutto per non aver considerato le conseguenze di una “Guerra-Non-Guerra” e il “cosa fare dopo” di breve e medio periodo. Da che mondo è mondo le cose fatte in fretta riescono sempre male e ovviamente, le opzioni politico-diplomatiche, teoriche o pratiche che siano, non sono immuni da tale assunto. Continua a leggere »